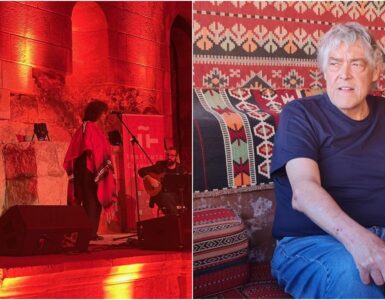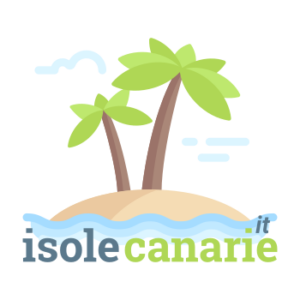Il fenomeno della calima ha colpito in modo particolarmente intenso le Isole Canarie nel 2020, creando disagi significativi e mai registrati prima. Gli impatti di queste condizioni atmosferiche non si limitano alle Canarie, ma si estendono anche alla Penisola Iberica, come dimostrato da eventi successivi. Questo articolo esplora in dettaglio gli effetti della calima, l’analisi dei dati e le condizioni meteorologiche che l’hanno determinata.

I fatti della calima del 2020 nelle Canarie
Il 22 e 23 febbraio 2020, gli otto aeroporti delle Canarie hanno dovuto interrompere le operazioni per quasi due giorni a causa di una calima particolarmente densa. Poco più di 120.000 passeggeri sono rimasti a terra, senza possibilità di decollare. Questo evento è stato prontamente riconosciuto come il più estremo mai registrato nella storia delle isole, un fatto che ha attratto l’attenzione dei ricercatori. Secondo il CSIC , si trattò di un fenomeno senza pari, principalmente a causa dell’intensità e della durata della calima. I passaggi aerei si sono bloccati mentre il cielo ha assunto un aspetto color arancione, segnalando la presenza di polvere sahariana che ha investito la regione.
L’episodio del 2020 ha rappresentato un significativo cambiamento nelle condizioni meteorologiche ed atmosferiche dell’arcipelago, scatenando diversi studi e ricerche che cercavano di capire meglio la natura e le cause di tale anomalia. Questo evento ha sollevato al contempo interrogativi sulle alternative di trasporto e sulla preparazione dell’infrastruttura aeroportuale in caso di simili situazioni future.
Analisi e conferme riguardo alle calime dell’ultimo decennio
Ricerche effettuate dal Gruppo di Atmosfera, Aerosoli e Clima dell’Istituto di Prodotti Naturali e Agrobiologia hanno confermato la natura “record” della calima del febbraio 2020, assieme a quella verificatasi nel marzo 2022. Sergio Rodríguez e Jéssica López-Darias, autori dello studio pubblicato sulla rivista ‘Atmospheric Chemistry and Physics‘, hanno contribuito a stabilire che le calime delle Isole Canarie non avevano eguali nel territorio spagnolo. Utilizzando una metodologia di ricostruzione dei dati, i ricercatori hanno affrontato le variazioni nei valori di concentrazione di polvere, che avevano superato il limite massimo misurabile dai dispositivi utilizzati.
In particolare, durante questi eventi, le concentrazioni di polveri PM10 hanno raggiunto valori massimi di quasi 5.000 microgrammi per metro cubico in punti specifici come Tenerife e Almería. A Gran Canaria, il valore record ha superato addirittura i 5.250 microgrammi per metro cubico. Questo ha evidenziato un drammatico aumento delle concentrazioni di polvere provenienti dal Sahara, sebbene prima di allora le calime sull’arcipelago avessero tipicamente valori oscillanti tra 200 e 400 microgrammi per metro cubico.
Le condizioni meteorologiche che favoriscono la calima
Il fenomeno delle supercalime di polvere sahariana si verifica in circostanze meteorologiche anomale. Secondo il CSIC, ciò è attribuito a una situazione di blocco anticiclone che colpisce il sud della Penisola Iberica e l’Europa Occidentale. Questo comportamento atmosferico devia i cicloni da ovest verso le Canarie e Cabo Verde, generando una configurazione meteorologica che favorisce venti est ivi particolarmente intensi. I vortici ciclonici e anticiclonici generano emissioni e trasporti di enormi quantità di polvere desertica, creando condizioni particolarmente difficili per la qualità dell’aria.
Sebbene lo studio non affermi un legame diretto tra questi eventi di calima e il cambiamento climatico, è importante notare che tali anomalie meteo influenzano l’intero emisfero settentrionale. Le caratteristiche di tali anomalie sembrano riflettere quelle associate al riscaldamento globale, un fenomeno che è stato provocato dalle emissioni di anidride carbonica legate all’attività umana. Questo richiede una continua riflessione e monitoraggio, sia a livello locale che globale, riguardo a come tali eventi influenzano la vita quotidiana e le politiche ambientali delle aree colpite.